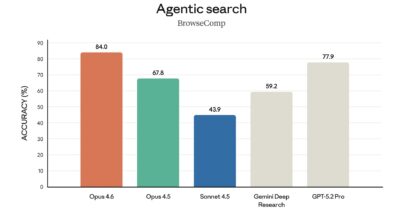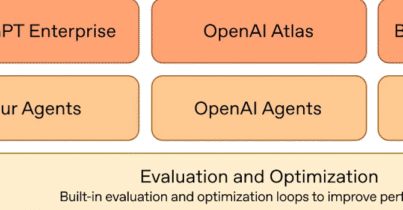A noi di Infodata, che da sempre abbiamo un debole per le mappe, non poteva sfuggire un progetto come BrainSTEM, una vera e propria rivoluzione nella conoscenza del cervello umano in via di sviluppo. Si tratta della mappa più dettagliata e completa mai realizzata delle cellule del cervello fetale, costruita a risoluzione di singola cellula, cioè osservando e analizzando una per una le cellule che compongono il cervello nelle sue prime fasi di formazione.
Il lavoro, pubblicato sulla rivista Science Advances, è frutto di una collaborazione internazionale guidata da un gruppo di ricercatori della Duke-NUS Medical School di Singapore, con la partecipazione di partner tra cui l’Università di Sydney.
Questo atlante rappresenta una delle analisi più ampie mai condotte sulla diversità cellulare del cervello fetale. E non si tratta soltanto di un traguardo tecnico o di un esercizio di catalogazione: i dati raccolti aprono nuove prospettive per la medicina rigenerativa e per la comprensione delle malattie neurodegenerative, in particolare il morbo di Parkinson.
Una mappa da 680.000 cellule
Per costruire questa enorme mappa, i ricercatori hanno identificato e analizzato quasi 680.000 cellule provenienti da cervelli fetali umani in diverse fasi di sviluppo di 39 donatori. Di ciascuna cellula sono stati tracciati il profilo genetico, il percorso di crescita e le relazioni con le altre cellule. Per arrivare a questo risultato, il team ha integrato due grandi banche dati preesistenti, entrambe basate su analisi a singola cellula ma relative a differenti aree e fasi dello sviluppo cerebrale. L’unione dei dataset ha permesso di costruire un atlante unico del cervello fetale umano, che copre un arco temporale che va dalla terza alla quattordicesima settimana dopo il concepimento.
Tra le popolazioni cellulari analizzate, un ruolo centrale è stato dato ai neuroni dopaminergici, cellule fondamentali per il controllo del movimento, dell’apprendimento e della motivazione. Questi neuroni, che si formano nel mesencefalo, sono anche quelli che degenerano nel Parkinson. Capire con precisione come si originano e maturano è quindi cruciale per poterli riprodurre in laboratorio e, un giorno, reintegrarli nei pazienti.
Un risultato particolarmente interessante riguarda la coerenza dei dati: le tipologie cellulari si sono raggruppate in modo uniforme e prevedibile, a conferma della solidità del metodo. Solo i campioni più precoci, relativi alle settimane 3 e 4, hanno mostrato differenze più marcate, poiché presenti esclusivamente in una delle due banche dati.
Un atlante disponibile in open source
Tutti i dati e gli atlanti generati dal progetto BrainSTEM – promettono gli autori – saranno disponibili in open source, insieme alla metodologia di mappatura multilivello. Questo significa che qualsiasi laboratorio potrà accedervi liberamente, replicare le analisi, isolare tipi cellulari specifici e applicare il metodo a nuovi studi. È un passo decisivo verso una scienza più trasparente e condivisa, capace di accelerare la scoperta e ridurre le barriere tra ricerca di base e applicazione clinica.
Perché questa mappa è così importante per la ricerca sul Parkinson
Il morbo di Parkinson è una delle più comuni malattie neurodegenerative: colpisce circa tre persone ogni mille oltre i 50 anni e interessa in Italia circa 300.000 persone. È causato dalla morte progressiva dei neuroni dopaminergici situati nella sostanza nera del cervello, un’area che produce la dopamina, il neurotrasmettitore che permette alle diverse regioni cerebrali di comunicare tra loro per coordinare i movimenti.
Quando la dopamina si riduce drasticamente, il cervello perde la capacità di controllare i movimenti in modo fluido. È allora che compaiono i sintomi tipici della malattia: tremore, rigidità muscolare, lentezza nei movimenti, ma anche alterazioni dell’equilibrio e dell’espressione facciale.
Le attuali terapie agiscono soprattutto sui sintomi, ma non fermano la progressione della malattia. Da qui l’importanza della ricerca su come rigenerare o sostituire i neuroni dopaminergici persi. Comprendere come queste cellule si formano durante lo sviluppo fetale è un passaggio chiave per poterle produrre in laboratorio e utilizzarle in terapie cellulari mirate.
Per affrontare questa sfida, i ricercatori di BrainSTEM hanno elaborato una strategia di mappatura a due livelli. Il primo livello offre una visione panoramica dell’intero cervello fetale, utile per individuare le principali regioni e i loro schemi di sviluppo. Il secondo livello, più approfondito, si concentra sul mesencefalo, dove vengono generati i neuroni dopaminergici, analizzandone nel dettaglio l’origine, la morfologia e i profili genetici.
Questa combinazione di analisi permette di confrontare i modelli in vitro, cioè i neuroni ottenuti da cellule staminali, con la biologia reale del cervello umano, definendo uno standard di riferimento globale. Solo così è possibile capire se i neuroni “artificiali” ottenuti in laboratorio somigliano davvero a quelli presenti nell’organismo umano.
Un driver per la ricerca
Lo studio BrainSTEM non solo offre una mappa dettagliata, ma mette in evidenza anche le criticità dei modelli oggi in uso nei laboratori. Gli autori hanno infatti scoperto che molti protocolli attualmente adottati per generare neuroni dopaminergici producono anche cellule indesiderate provenienti da altre aree cerebrali. Queste popolazioni “off-target” possono falsare i risultati e ridurre l’efficacia dei trapianti.
Applicando la loro strategia di analisi a due livelli, i ricercatori hanno riesaminato in modo sistematico i dataset esistenti di colture di mesencefalo umano. Il confronto ha confermato la presenza di vere popolazioni di cellule “on-target”, ma ha anche rivelato una quota significativa di cellule “fuori bersaglio” che avevano portato, in passato, a sovrastimare la produzione di neuroni dopaminergici.
Infine, la possibilità di mappare il cervello fetale a livello di singola cellula apre la strada a una nuova generazione di strumenti basati su intelligenza artificiale. I dati ottenuti da BrainSTEM potranno essere utilizzati per costruire modelli predittivi capaci di classificare in modo più preciso le diverse popolazioni cellulari, individuare pattern di malattia e, in prospettiva, personalizzare le terapie in base alle caratteristiche molecolari di ciascun paziente.
Per approfondire.
Il cervello umano visto da vicino #imaging
La Cina punta a mappare il cervello umano entro 25 anni. Con o senza gli Stati Uniti
Nasce BraDiPho, la mappa digitale delle connessioni neuronali