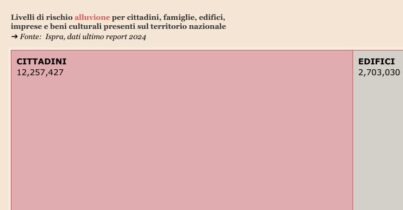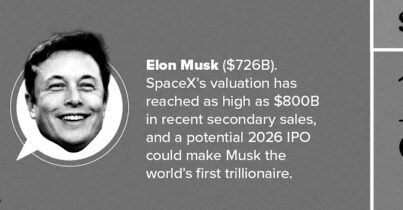Nel 1950 una persona su 20 aveva più di 65 anni. Nel 2021 è over-65 un individuo ogni 10 e nel 2050 lo sarà 1 su 6. Dal momento che invecchieremo, la questione è come invecchiare con meno problemi di salute possibile. Fare in modo cioè di rallentare alcuni processi che oltre all’età cronologica fanno aumentare la nostra età biologica.
La geroscienza è una disciplina relativamente nuova che invece di concentrarsi sul prevenire (o curare) una singola patologia, valuta terapie che intervengono direttamente sui percorsi cellulari legati all’invecchiamento e che portano a una maggiore incidenza di malattie. L’ipotesi è che agendo sui principali motori dell’invecchiamento a livello cellulare, si possano prevenire simultaneamente diverse patologie che hanno nell’età avanzata il loro principale fattore di rischio. L’ipotesi geroscientifica introduce un concetto fondamentale: l’invecchiamento biologico è un processo distinto e misurabile, che non sempre coincide con l’età cronologica. Tuttavia, il concetto stesso di età biologica, sebbene ancora privo di una misura universalmente accettata: si basa al momento sulla valutazione di parametri fisiologici, molecolari e clinici.
Lo stato attuale della geroscienza è un insieme di ipotesi che iniziano a essere fondate su esperimenti per lo più condotti su modelli animali. Una prima revisione della letteratura è da poco apparsa su JAMA, e racconta che cosa sappiamo davvero sull’ “età biologica” e quali sono gli approcci a oggi più promettenti per rallentare l’invecchiamento cellulare.
Quali indicatori osservare
I primi tentativi di misurare l’età biologica si basavano su test clinici di routine e valutazioni fisiologiche. Questi includono, ad esempio, l’ampiezza della distribuzione dei globuli rossi o i livelli di creatinina sierica. Misurazioni più specifiche possono includere la capacità vitale forzata (la quantità massima di aria che una persona può espirare dopo aver inspirato) o il consumo massimo di ossigeno (VO2max), che riflette la capacità del corpo di utilizzare l’ossigeno durante l’esercizio fisico. Per esempio, una donna di 50 anni con un VO2max tipico di una donna di 40 anni, verrebbe considerata con un’età biologica di 40 anni.
Un altro approccio si basa sull’analisi del pattern delle coppie di basi del DNA metilato. La metilazione è un processo epigenetico che regola l’espressione genica e che subisce alterazioni specifiche con l’avanzare dell’età. Queste variazioni possono fungere da una sorta di “orologio biologico” che riflette l’età a livello molecolare. Studi come quello condotto sulla coorte di Saint Jude, su 4.117 sopravvissuti a un cancro infantile, hanno mostrato che a 35 anni di età, questi individui avevano un’età biologica da 2,2 a 6,5 anni superiore rispetto a un gruppo di controllo, calcolata con diversi metodi, inclusa la metilazione del DNA.
La risonanza magnetica (RM) cerebrale può essere utilizzata per stimare l’età cerebrale, confrontando le caratteristiche strutturali del cervello di un individuo con quelle di un vasto database di persone di diverse età. A tal proposito, in uno studio su 1.771 partecipanti, una differenza tra età cerebrale e cronologica superiore a 1,75 anni è stata associata a un tasso di mortalità 2,6 volte superiore nei successivi 8 anni.
Un altro approccio prevede l’analisi di pannelli di proteine circolanti nel sangue, come la proteina GDF-15 e la cistatina C, che possono essere indicatori dello stato di salute legato all’età.
Infine, i biologi specializzati nell’invecchiamento stanno identificando percorsi cellulari specifici che influenzano la durata e la salute della vita. Questi includono la regolazione dei telomeri, la omeostasi proteica (il mantenimento di una corretta struttura e funzione delle proteine), l’autofagia (il processo di eliminazione delle proteine danneggiate), e la funzione mitocondriale. L’accumulo di danni in queste vie biologiche, ad esempio a causa della generazione di radicali dell’ossigeno o di variazioni genetiche, può portare a una disfunzione cellulare e all’invecchiamento.
Quali approcci sembrano funzionare contro l’invecchiamento?
Un esempio interessante è la restrizione calorica. Si è visto che nei topi, la restrizione calorica aumenta la durata media della vita dal 10% al 40% rispetto ai topi alimentati ad libitum e influisce favorevolmente su molteplici percorsi cellulari implicati nell’invecchiamento, tra cui il rilevamento dei nutrienti, la sintesi proteica, l’autofagia e l’infiammazione. Negli adulti con obesità e diabete, rispetto ai gruppi di intervento senza restrizione calorica, la randomizzazione a ricevere restrizione calorica è stata associata a una riduzione del 15% della mortalità per tutte le cause e a una minore incidenza di malattie croniche correlate al peso.
Un’altra area di ricerca affascinante riguarda le cellule senescenti, che si accumulano nel corpo con l’avanzare dell’età. Caratterizzate da arresto della crescita, resistenza all’apoptosi e un secretoma alterato (l’insieme di proteine secrete da una cellula nello spazio extracellulare) sono associate a una maggiore fragilità fisica e a un aumento della mortalità. La riduzione del numero di queste cellule nei modelli animali prolunga la durata della vita e migliora le funzioni fisiche, come la forza di presa e la mobilità, e la frazione di eiezione cardiaca. Tuttavia, i potenziali benefici per la salute derivanti dalla riduzione delle cellule senescenti negli esseri umani – concludono gli autori – rimangono poco chiari.
La geroscienza sta ancora vivendo la sua pre-adolescenza: stanno emergendo molti studi, con risultati contrastanti fra loro, che richiederanno tempo per essere consolidati. Studi su primati e sull’uomo – per esempio – hanno evidenziato miglioramenti nella memoria e una minore perdita di spessore di alcune aree cerebrali, insieme a un rallentamento di altri segni di invecchiamento muscolare e cellulare in soggetti a cui era somministrata la metformina, farmaco di prima linea per il diabete di tipo 2. Tuttavia, altri trial clinici come UKPDS e Diabetes Prevention Program (DPP) non hanno dimostrato vantaggi duraturi rispetto agli interventi sullo stile di vita per prevenire fragilità, declino cognitivo o altre malattie legate all’età.