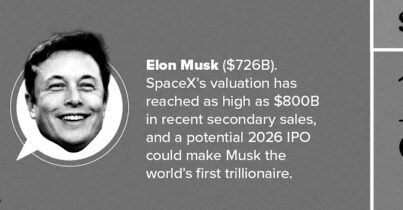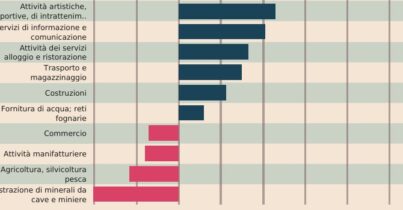Il progetto “Virtual Dog”, finanziato dal National Centre for the Replacement, Refinement and Reduction of Animals in Research (NC3Rs) insieme a sette grandi aziende farmaceutiche mira a sviluppare un modello di machine learning capace di prevedere se una determinata sostanza chimica potrebbe risultare tossica per i cani.
Nella primavera scorsa la FDA e l’Agenzia per la Protezione Ambientale hanno annunciato che non sarà più obbligatorio ricorrere ai test sugli animali per alcune classi di farmaci e sostanze chimiche in fase di valutazione, inclusi i pesticidi. La prospettiva è quella di sostituire gradualmente gli animali con una gamma di strumenti innovativi che vanno dai sistemi di coltura cellulare tridimensionale agli organoidi, fino agli algoritmi di intelligenza artificiale in grado di prevedere gli effetti tossici di una molecola sulla base della sua struttura.
È un dibattito che divide la comunità scientifica e l’opinione pubblica: fino a che punto è possibile sostituire i test sugli animali nella ricerca biomedica? Da decenni la sperimentazione animale rappresenta uno snodo cruciale nello sviluppo di nuovi farmaci e sostanze chimiche, ma i suoi limiti sono sempre più evidenti. Eppure, l’idea di superarla del tutto resta problematica, tanto sul piano scientifico quanto su quello normativo ed etico.
Due esempi di sistemi che funzionano
Il primo esempio è un “fegato su chip” prodotto dall’azienda biotecnologica di Boston Emulate Inc. Il dispositivo è progettato per replicare alcune funzioni dell’organo umano e testare la sicurezza dei farmaci. In particolare, il chip si concentra su una condizione che rappresenta un incubo per le aziende farmaceutiche: il danno epatico indotto da farmaci (DILI). Questa forma di tossicità epatica è responsabile da sola del 22% dei fallimenti nelle sperimentazioni cliniche. Ancora più complesso è il fatto che spesso il danno epatico non emerge nei test sugli animali, rivelandosi solo quando i farmaci arrivano sull’uomo.
Uno studio recente ha mostrato che il chip di Emulate è stato in grado di identificare con l’87% di accuratezza i farmaci noti per causare DILI e con il 100% quelli che non lo provocano.
Il laboratorio di Thomas Hartung presso la prestigiosa Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, ad esempio, da prima del 2018 lavora a uno strumento di previsione basato sull’intelligenza artificiale, addestrato su circa 10 milioni di strutture chimiche note provenienti da un database chiamato PubChem e su informazioni provenienti da dossier presentati dalle aziende alle autorità di regolamentazione statunitensi ed europee sulle proprietà delle sostanze chimiche e sui rischi noti per la salute. Eseguendo migliaia di miliardi di confronti tra le sostanze chimiche, l’algoritmo ha imparato a prevedere il comportamento delle nuove sostanze chimiche in nove test tradizionalmente condotti sugli animali, come le valutazioni di irritazione oculare e mutazioni genetiche. Le sue previsioni si sono allineate ai risultati dei test sugli animali nell’87% dei casi, più spesso di quanto i test sugli animali stessi possano essere riprodotti. Science riporta che una versione più recente dello strumento, non ancora pubblicata, è stata addestrata su 260 milioni di punti dati e prevede 4000 proprietà di nuove sostanze chimiche con una precisione del 91%.
Gli Stati Uniti spingono per l’IA
Questa trasformazione ha già messo in movimento un intero settore industriale. Decine di start-up e aziende biotecnologiche sono nate con l’obiettivo di sviluppare organi sintetici e piattaforme di analisi predittiva, mentre le grandi multinazionali del farmaco hanno iniziato a integrare sistematicamente queste tecnologie nei loro laboratori. Il governo statunitense, consapevole di questi limiti, da tempo autorizza test in vitro e modelli cellulari come integrazione agli studi animali, soprattutto in settori specifici come quello dei pesticidi. Negli ultimi anni però il sostegno si è ampliato. Gli investimenti dei National Institutes of Health (NIH) in alternative alla ricerca sugli animali sono aumentati costantemente negli ultimi anni. I progetti che utilizzano sistemi non animali rappresentavano l’1,1% di tutti i finanziamenti per la ricerca del NIH, nuovi e rinnovati, assegnati nel 2000 e sono cresciuti all’8% nel 2024. La stessa agenzia ha creato un nuovo ufficio per l’innovazione e la validazione dei NAM, con il compito di favorire la diffusione di queste tecnologie, finanziare nuovi progetti e superare i pregiudizi a favore della ricerca tradizionale sugli animali che ancora condizionano parte della comunità scientifica.
Europa più cauta
La spinta non si ferma agli Stati Uniti. Anche in Europa il tema è al centro dell’agenda politica e regolatoria. La Commissione Europea ha annunciato la pubblicazione di una roadmap per l’eliminazione graduale della sperimentazione animale nella valutazione della sicurezza chimica, mentre l’Agenzia Europea per i Medicinali sta discutendo la possibilità di accettare i dati provenienti dai NAM nelle decisioni su trial clinici e approvazioni di nuovi farmaci.
Cosa bisogna ancora chiarire
Nonostante lo slancio, nessun modello è ancora in grado di riprodurre appieno la complessità della biologia umana e soprattutto il coordinamento tra organi diversi. Oggi circa nove farmaci su dieci che si mostrano sicuri negli studi preclinici falliscono poi nelle sperimentazioni cliniche, spesso a causa di effetti collaterali imprevisti. Una discrepanza che deriva in parte dalle differenze profonde tra la fisiologia animale e quella umana e che si traduce in costi enormi e tempi più lunghi per lo sviluppo di nuove terapie.
Gli strumenti di intelligenza artificiale, per quanto promettenti, dipendono fortemente dalla qualità dei dati su cui vengono addestrati e non sempre sono in grado di gestire la complessità delle piccole molecole, che interagiscono con numerosi bersagli cellulari e producono metaboliti dalle proprietà difficili da prevedere.
Il dibattito resta aperto e, come spesso accade nella scienza, la realtà si colloca in una zona grigia tra due visioni contrapposte. Il futuro che si delinea è quindi quello di una convivenza. Da un lato, organoidi, chip d’organo e piattaforme di intelligenza artificiale offriranno strumenti sempre più precisi per identificare rischi specifici e per selezionare con maggiore accuratezza i candidati farmaci. Dall’altro, gli animali continueranno a rappresentare un passaggio inevitabile almeno in alcuni contesti, soprattutto quando si tratta di valutare effetti complessi e interazioni su più organi e sistemi. È un percorso di riduzione, più che di abolizione, che porta con sé la promessa di un cambiamento epocale ma che, almeno per ora, non può ancora mantenere la speranza di una sostituzione totale.